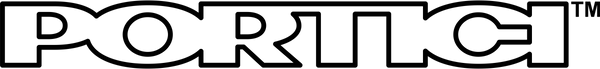É semplice così, se puoi permetterti di comprare una bicicletta, compri una bicicletta, compri un catenaccio resistente e vai a lavoro ogni giorno sulla tua bicicletta.
Ma se non puoi permetterti una bicicletta, se non hai abbastanza soldi da parte nemmeno per il più scarso degli usati, allora ne noleggi una. Prendi una mobike tutte le mattine per andare a lavoro. Alla fine dell’anno, con quei soldi, avresti comprato 10 biciclette.
É così che Giovanni, un amico, un giorno di primavera, mi spiegava come i ricchi spendessero meno soldi dei poveri. É semplice così.
Il Rapporto annuale dell’ISTAT 2025 è uscito il 21 maggio. Nella sezione che analizza “popolazione e società” vengono ritratte le recenti condizioni economiche delle famiglie residenti in Italia. La povertà assoluta coinvolge, nel 2023, l’8,4% delle famiglie residenti. In particolare, le categorie più fragili sono le famiglie con figli giovani, gli stranieri e i residenti nel Mezzogiorno.
Eppure l’Italia non è un Paese povero! Il problema della nostra penisola è una parola che possiamo incollare a ognuno dei gravi drammi sociali e pubblici che occupa le animate conversazioni politiche: la “disuguaglianza” che, nel caso specifico dei soldi, si traduce in mal distribuzione delle ricchezze. L’Italia è un Paese ricco, i soldi sono in mano a pochi.
E il resto come sopperisce? Lavorando duro, questa è una filastrocca intessuta nella nostra Costituzione, eppure l’Italia è uno dei pochissimi Paesi dell’Unione Europea in cui manca una normativa sul salario minimo!
A noi italiani piacciono disuguaglianze e ipocrisia insomma.
Il salario minimo è una tutela fondamentale che in Francia esiste sin dal 1950 e in Spagna dal 1963 ed è una di quelle parole composte che sa di diritti, non ne sentite l’odore di rispetto e quell’amaro gusto di dignità? Un piatto perfetto.
Il salario minino maggiore si registra in Lussemburgo dove arriva a 2.387,40 euro al mese, una cifra che moltissime famiglie italiane non vedono raggiungere a nessuno dei loro membri. E stiamo parlando solo di salario minimo! Non di stipendio medio, di statistiche improntate su una determinata fascia di lavoratori. No, in Lussemburgo un occupato guadagna almeno 2.387,40 euro. In Lussemburgo più o meno tutti possono permettersi di andare a lavoro in bicicletta, ma chi non riesce a comprarla può comunque usare i mezzi pubblici che sono completamente gratuiti per cittadini e turisti. A Bologna il biglietto della TPER è aumentato di più del 50%, ora una corsa in autobus costa 2 euro e 30. Non c’è salario minimo e raggiungere il posto di lavoro già ne confisca una buona parte.
Tra i lavoratori italiani dilaga l’instabilità economica. Nonostante il numero di persone lavoranti all’interno del nucleo familiare aumenti, il netto degli stipendi non riesce a garantire quello che il Rapporto definisce “un livello di vita adeguato”. Quella del salario è una fragilità che, si sa, colpisce in maniera più frequente le donne, i giovani sotto ai 35 anni e gli stranieri. Così nel 2023, il 21,0% dei lavoratori risulta a basso reddito.
Se solo ci fossero soldi con cui lo Stato italiano può sopperire alle sue mancanze o aiutare quella gran fetta della popolazione a ottenere quell’ambito “livello di vita adeguato”.
Eppure viviamo in un Paese che a febbraio del 2025 ha speso meno di un terzo dei fondi del PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e verrebbe da chiedersi perché visto che i progetti avviati sono a buon punto.
Allora, un po’ giocando tra fantasia e speculazione, mi immagino i contabili che ne gestiscono le uscite seduti a un tavolino, insieme agli statisti, ai rappresentanti del nostro Governo e a tutto il personale incaricato, e chissà chi è il primo che parla e chiede:
“Dove li spendiamo questi 194 miliardi di euro?”.
Chiunque sia stato, la domanda l’ha fatta nel 2021, nell’estate in cui il piano è stato approvato.
E forse è un po’ come quelle mattine in cui hai troppe cose da fare, talmente tante che ti fermi a riflettere su come ordinarle, su cosa sia più importante: portare fuori il cane, fare la spesa, andare a lezione, salutare quell’amico che ti ha chiesto un caffè dieci anni prima, lavorare a quella consegna che dovevi ultimare ieri, andare in palestra…
Ecco, forse è un ritratto immaginabile pensarli seduti, come in un’ultima cena davinciana, a contemplare una lista infinita di lacune, problemi e mancanze e dirsi incapaci di decidere a quale destinare i primi fondi. Ma per fortuna possono posticipare la sveglia e dormire un altro pochino, almeno fino a metà 2026, quando, inesorabilmente, il piano scade.
Chissà se anche loro si presenteranno a scuola con il compito mangiato dal cane o chiederanno di rimandare la verifica dicendo alla Nazione che non hanno avuto tempo.
Giovanni me lo spiegò con le biciclette, Daron Acemoglu ci vinse il Nobel lo scorso anno. Uno degli economisti più influenti al mondo, professore al MIT di Boston e ospite speciale del Festival dell’Economia a Trento (sì, lo fanno ed è estremamente interessante, link in fondo all’articolo). Nel suo intervento (il link in fondo all’articolo porterà a questo) Acemoglu spiega quel che vinse a lui, e al collega Simon Johnson il Nobel lo scorso anno: la compartecipazione attiva delle istituzioni e dei governi sull’impatto della prosperità delle Nazioni e sull’influenza nella differenza di reddito tra i Paesi e la loro evoluzione al passo del progresso tecnologico.
Il Medioevo e la Rivoluzione Industriale inglese sono solo due degli esempi che cita l’economista: due dei più grandi esempi che studiamo a scuola per imparare il progresso, emblemi dell’evoluzione tecnologica e umana. Acemoglu fa notare come questi momenti storici non coincidano con una crescita per tutte le fasce della popolazione. È fondamentale chiedersi sempre chi beneficia del progresso e chi ne viene danneggiato. I salari non sono aumentati, i lavoratori non hanno acquisito più diritti e la macchina ha sostituito l’uomo invece di aiutarlo. Qualcuno aveva più soldi in tasca e gli altri morivano di fame.
Per la maggior parte delle persone il lavoro non è solo un diritto, ma un’esigenza. Io sono tra queste. Il primo lavoro che ho fatto in città è stato in un negozio specializzato in arredamenti. Smontavo e rimontavo, pulivo, assistevo clienti, prezzavo, organizzavo il magazzino e allestivo il negozio. E poi tornavo a casa stanca, stanca e frustrata. Stanca perché avevo trainato mobili a destra e sinistra, in alto e in basso tutto il giorno. Frustrata perché mi avevano assunta con un contratto da stagista, solo perché ero abbastanza giovane da consentirgli di farlo, e mi pagavano 450 euro al mese per lavorare 7 ore al giorno per 6 giorni. A voi i calcoli. La mia collega che aveva finito i 6 mesi di stage, veniva pagata 800.
Eppure i soldi mi servivano, per aiutare i miei genitori a pagare l’affitto a Bologna, altro velo pietoso che copre e rovina questa meravigliosa città. L’affitto mi serviva per vivere qui, vivere qui mi serviva per studiare. Poi sono stati i miei genitori a dirmi di lasciare il lavoro, ma ricordo di quei mesi una domanda che insisteva tamburellandomi dentro la testa:
“Ma com’è possibile che sia legale?”
FONTI
Rapporto Annuale 2025, ISTAT, Rapporto annuale 2025 – Istat
Intervento di Daron Acemoglu, Festival dell’Economia, Trento, 2025 La lotta infinita tra potere e progresso nell’era dell’intelligenza artificiale | Trento Festival dell'Economia 2025